
Passata la sbornia olimpionica, terminate le polemicucce sul burkini e a poche ore dal celebratissimo vertice di Ventotene, stamane l’Italia si è risvegliata brutalmente ferita da un terremoto notturno che ha flagellato il centro della penisola cancellando interi paesi, mettendone in allarme molti altri e prendendosi decine di vite. Uno sciame di scosse – due in particolare, ad un’ora di distanza – di alta intensità ha così messo in ginocchio una parte del Paese, ammutolendone l’altra, e restituendoci immagini destinate a restare nella memoria: l’infermiera che urla di scappare fuori, le case crollate a decine, il parroco di Amatrice che piangendo si augura di poter «trovare il coraggio per andare avanti».
Lo scenario è tremendo, disperante, apocalittico. Certo, c’è la gara di solidarietà, c’è la corsa agli aiuti e a donare il sangue, c’è l’Italia che soccorre se stessa riscattando – come altre volte ha fatto – ombre piccole e grandi che troppo spesso ne offuscano il volto. Però l’angoscia resta e soprattutto rimane la consapevolezza, prepotentemente tornata a dominare i pensieri, di essere alla fine tutti impotenti. No dico, ma ci rendiamo conto? L’esaltazione del progresso, l’allontanamento strafottente di Dio dalla vita pubblica, i pronostici di un futuro tecnologico e luminoso e poi basta che le viscere della terra brontolino appena ed eccoci qua, senza parole, a leccarci tremanti le ferite con l’augurio che stanotte vada meglio.
Credo che tutto questo – oltre a spingerci al mostrare vicinanza alle vittime in tutte le forme possibili, dalla spirituale alla solidaristica – debba fungere da avvertimento o se volete da promemoria, per tutte le volte che ci trastulliamo con quelle ambizioni ridicole, con quei piaceri effimeri e quelle conquiste volatili che altro non sono che tasselli del mosaico del Niente. La vita è breve e a volte amara, anzi amarissima da mandare giù. Per questo occorre un orizzonte di Senso, qualcosa – o più precisamente Qualcuno – che ci faccia evadere dal variopinto perimetro delle cose che contano poco per consentirci non di diventare eroi, ma di tornare uomini che sanno di essere uomini, impermeabili alla retorica e familiari alla finitudine.
Riscoprirsi umani, sia chiaro, non basterà. Ci ridesterà, d’accordo, senza però risparmiarci la vulnerabilità e senza farci mai sopportare, soprattutto, quel dolore innocente e quel pianto da esso sgorga, come sangue dell’anima per altre anime che se ne sono andate. Eppure il sentiero della fragilità, dell’insuperabile fragilità dell’essere umani è il solo percorribile quando crollano case e certezze, quando tutto attorno si crea un vuoto così enorme che può essere riempito solo dalla Disperazione o dalla Speranza, dal vortice che risucchia la vita rimasta o dal faro che porta a rialzarsi in nome e memoria di quella che non c’è più; non per guadagnare chissà cosa o per raggiungere chissà quali traguardi ma per abbracciarsi fra reduci ed avere, se possibile, un po’ meno paura.
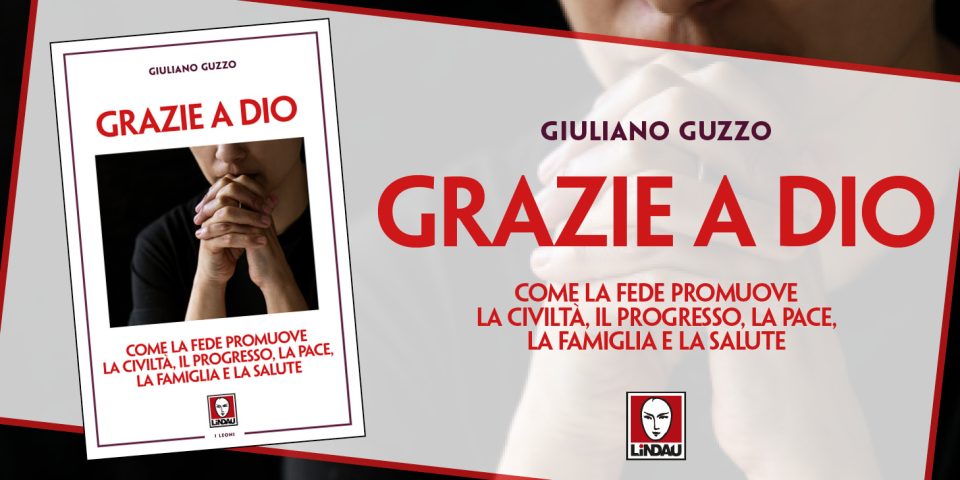
Pingback: Il terremoto e il panico dell’umanità reduce | Freedom24news.eu - Ultime notizie su politica, attualità e cronaca nazionale e siciliana
«…No dico, ma ci rendiamo conto? L’esaltazione del progresso, l’allontanamento strafottente di Dio dalla vita pubblica, i pronostici di un futuro tecnologico e luminoso e poi basta che le viscere della terra brontolino appena ed eccoci qua, senza parole, a leccarci tremanti le ferite con l’augurio che stanotte vada meglio».
L’esaltazione del progresso? Tutti, Lei compreso, potremmo rinunciare all’esaltazione del progresso e a non usufruirne e scegliere di ritornare a vivere nelle caverne ad accendere il fuoco con la pietra focaia. Tuttavia non mi pare ci sia questo frenetico slancio nell’andare a ritroso.
L’allontanamento strafottente di Dio dalla vita pubblica? Quando Dio era parte integrante della vita pubblica e privata, quando cioè Dio faceva mondo, le cose non andavano certo meglio: carestie, pandemie, terremoti e via dicendo si susseguivano a piene mani senza sosta.
E quindi?
Tutti… potremmo rinunciare all’esaltazione del progresso e a non usufruirne e scegliere di ritornare a vivere nelle caverne ad accendere il fuoco con la pietra focaia. Tuttavia non mi pare ci sia questo frenetico slancio nell’andare a ritroso.
La questione é tutta nel valutare cosa si intenda per progresso. Se il progresso serve al bene comune, migliora il tenore di vita, riduce le povertà, ecc.. non può che essere bene accetto. Se il progresso talora viene a coincidere con la conclusione che basta “stia meglio io” e degli altri “non mi interessa un fico secco” ovvero il progresso impone l’annullamento “a priori” di valutazioni etiche su procedure e comportamenti, ecc… le cose sono un poco diverse.
Quando Dio era parte integrante della vita pubblica e privata, quando cioè Dio faceva mondo, le cose non andavano certo meglio: carestie, pandemie, terremoti e via dicendo si susseguivano a piene mani senza sosta. E quindi?
Sarà invece che la visione escatologica abbia agevolato nella vittoria su carestie, pandemie (terremoti non ancora per adesso…) e via dicendo?
Riuscire a valutare che cosa sia vero progresso e cosa non lo sia, è questione assai spinosa e di non facile soluzione, che investe aspetti etici ed esistenziali e come tali sottoposti al giudizio dei singoli individui. Ciò che eticamente appare accettabile a Tizio può non esserlo a Caio con buona pace dell’indifferente Sempronio.
Il progresso è alimentato dall’inesauribile desiderio di conoscenza dell’uomo e procede ineluttabile e tutti noi, chi più chi meno, ne usufruiamo. Meglio sarebbe condannare l’imbecillità dell’uomo, quando quel progresso volutamente ignora e non applica per esempio, per criminale tornaconto le tecniche costruttive innovative. Laddove quelle tecniche si utilizzano i terremoti causano danni infinitamente minori e poche vittime.
Ciò detto, evidenziare le reali fragilità dell’uomo e la consapevole impotenza che ci connota tutti di fronte ai cataclismi e alla morte, non giustifica il tentativo dell’amico Guzzo di voler suggerire tra le righe che la causa delle calamità naturali siano la diretta conseguenza dell’esaltazione del progresso e l’allontanamento strafottente di Dio dalla vita pubblica. Quando lo strumento tecnologico era agli albori e la presenza di Dio era imposta, spesso in modo cruento e ossessivo le cose non andavano meglio.
Non so se la visione escatologica abbia o no agevolato determinate conquiste. A vincere le carestie è stata la meccanizzazione dell’agricoltura prima e in seguito l’utilizzo di tecniche biologiche raffinate, tuttora in forte evoluzione, tese a migliorare il prodotto, a incrementarne la produzione e a rafforzare la resistenza ai parassiti. Senza dimenticare l’utilizzo del freddo per la conservazione degli alimenti nel tempo.
A vincere le pandemie, a debellare terribili malattie e a incrementare l’aspettativa media di vita fino a superare il limite degli ottant’anni sono stati i vaccini, i farmaci sempre più potenti e mirati, le tecniche diagnostiche fino a ieri inimmaginabili e una chirurgia capace di realizzare veri e propri miracoli.
Se poi vogliamo anche tener conto e ringraziare la visione escatologica, nulla lo vieta. In fondo costa nulla.
Gentile Marino, ricordiamoci pero’ che fondamentalmente la Scienza e’ nata qui, in Occidente, durante il Medioevo Cristiano e poi ha preso il volo nel XVI e XVII secolo nell’Europa Cristiana. La visione filosofica del Cristianesimo e’ stata assai importante, se non fondamentale: l’Universo e’ prodotto di un Dio razionale che pero’ non interviene in esso a caso. Quindi l’Universo stesso e’ una costruzione razionale e libera da influenze soprannaturali che la ragione dell’Uomo puo’ indagare. Gli scolastici incoraggiavano la logica e l’analisi razionale dell’Universo e gli esperimenti con i fenomeni naturali; basti citare Alberto Magno, Ruggero Bacone e gli Oxford Calculators. La Scienza moderna nacque cosi’.
Sono tutte cose che i massimi studiosi della Storia della Scienza hanno appurato da tempo. Per esempio, Pierre Duhem e Edward Grant, David Lindbergh e Ronald Numbers, tanto per citare un paio di vincitori delle piu’ alte onorificenze per le ricerche sulla Storia della Scienza.
Puo’ leggere una breve sintesi del pensiero degli autori citati nel libro “God’s Philosophers: How the Medieval World Laid the Foundations of Modern Science”, che e’ stato insignito dalla Royal Society Prize for Science Books nel 2010.
Tra l’altro Lei ripete, nemmeno tra le righe, la solita idea del “la presenza di Dio era imposta, spesso in modo cruento e ossessivo”. A parte che nel XX secolo, verrebbe da dire, e’ stato l’ateismo ad essere stato imposto in maniera molto piu’ cruenta ed ossessiva, Lei commette il classico errore del “presentismo”, vale a dire giudica il passato con i criteri etico-morali frutto dell’illuminismo e del liberalismo, movimenti nati sviluppatisi nel XVIII e XIX secolo. Tanto vale giudicare i nostri antenati rozzi ed ignoranti perché non sapevano guidare l’automobile od usare Excel. Lei, un uomo del XXI secolo, vorrebbe forse essere giudicato negativamente nel XXIV secolo in base ad idee nate nel XXII, che Lei adesso ovviamente ignora? La Religione in passato era ritenuta un qualcosa di comunale, di condiviso da tutti, non una scelta di libertà individuale; quest’ultimo concetto non era stato inventato nel Medio Evo.
Lei scrive “non giustifica il tentativo dell’amico Guzzo di voler suggerire tra le righe che la causa delle calamità naturali siano la diretta conseguenza dell’esaltazione del progresso e l’allontanamento strafottente di Dio dalla vita pubblica.”
Le parole di Guzzo suggeriscono che le *calamita’ naturali siano la diretta conseguenza dell’esaltazione del progresso e dell’allontanamento di Dio*? Ma quando, ma dove ha letto queste cose?
Mi permetta, forse un po’ piu’ di attenzione non Le farebbe male.
A me le parole di Guzzo sembrano l’amara annotazione che la vita umana rimane ancora fragile e soggetta, pure al giorno d’oggi, a calamita’ naturali che in un attimo cancellano le nostre esistenze e le nostre cose materiali, che ci sembravano cosi’ sicure e solide poco prima.
Io non dimentico nulla gentile Max e per quanto mi riguarda, senza scomodare nessuno dei personaggi chiamati in causa, non ho mai avuto dubbi sul dove la scienza è nata e cioè in Occidente durante il Medioevo cristiano.
Non v’è dubbio che in passato la religione era ritenuta un qualcosa di comunale condiviso e non una scelta di libertà individuale, giacché quest’ultimo concetto non era ancora stato elaborato. E tuttavia non è vero che quella concezione era condivisa da tutti. Quei pochi che possedevano le necessarie attitudini per ragionare e proporre pubblicamente punti di vista non allineati erano costretti a tacere, a ritrattare o a subire conseguenze spesso cruente. È quindi legittimo il mio ripetere e nemmeno tra le righe che “la presenza di Dio era imposta, spesso in modo cruento e ossessivo”. E se oggi non accade più, non è certo per merito della Chiesa cattolica.
L’amara e legittima annotazione di Guzzo nell’evidenziare la fragilità della vita umana, soggetta, pure nel presente, a calamità naturali che in un attimo cancellano le nostre esistenze è stata da me sposata e riproposta, senza però aggiungere quel di più rappresentato da quel richiamo: «… No dico, ma ci rendiamo conto? L’esaltazione del progresso, l’allontanamento strafottente di Dio dalla vita pubblica, i pronostici di un futuro tecnologico e luminoso e poi basta che le viscere della terra brontolino appena ed eccoci qua, senza parole, a leccarci tremanti le ferite con l’augurio che stanotte vada meglio».
Parole a mio parere fuori luogo e inutili, che tendono a far intravvedere, in un modo pseudo subliminale, la relazione tra il comportamento “strafottente” degli uomini d’oggi e le catastrofi. Un richiamo inutile, poiché anche se non esaltassimo il progresso e non fossimo così strafottenti da allontanare Dio dalla vita pubblica e privata, rimarrebbero intatti la nostra fragilità e l’impotenza di fronte alla morte.
Buona domenica.
[…]
e per quanto mi riguarda, senza scomodare nessuno dei personaggi chiamati in causa, non ho mai avuto dubbi sul dove la scienza è nata e cioè in Occidente durante il Medioevo cristiano.
[…]
Bene, quindi senza scomodare nessuno degli eccellenti ricercatori menzionati sopra, non ci sono dubbi che dobbiamo anche alla filosofia cristiana la lista degli sviluppi scientifici e tecnologici da Lei menzionata sopra.
Mi permetto di dire, attribuire anche alla filosofia cristiana queste importanti conquiste che hanno contribuito a migliorare la qualità della vita non solo non costa nulla, e’ anche una doveroso rispetto per la verita’.
[…]
Quei pochi che possedevano le necessarie attitudini per ragionare
[…]
Perche’ secondo Lei c’erano pochi eletti che, capaci di ragionare meglio della massa di tutti gli altri che non ragionavano, non potevano essere d’accordo sull’esistenza di Dio? Mi scusi, questo mi sembra un ragionamento un po’ razzista.
Una cosa importante da ricordare in questo contesto e’ che sostanzialmente non c’erano atei prima del XVII-XVIII secolo. C’erano persone che non si allineavano, piu’ o meno, con l’ortodossia, ma non esiste documento che accusi una o piu’ persone di non credere all’esistenza di Dio nel Medio Evo.
[…]
È quindi legittimo il mio ripetere e nemmeno tra le righe che “la presenza di Dio era imposta, spesso in modo cruento e ossessivo”.
[…]
Lei lo puo’ legittimamente ripetere, purché allo stesso tempo eviti giudizi del tipo giusto e sbagliato che, sospetto, fa capolino dalle sue parole “cruento ed ossessivo”. Non possiamo giudicare il passato con gli stessi standard del presente.
Semmai e’ molto piu’ grave quello che e’ successo in pieno XX secolo, con gli ideali di libertà individuale gia’ ben presenti nella civilta’ Occidentale. Si e’ cercato di estirpare in maniera estremamente crudele la religione, violando (uso un eufemismo) il diritto di libertà’ individuale degli individui di credere in cio’ che essi vogliono.
Altro che il Medio Evo, che era molto distante da noi non solo temporalmente.
[…]
senza però aggiungere quel di più rappresentato da quel richiamo: «… No dico, ma ci rendiamo conto? L’esaltazione del progresso, l’allontanamento strafottente di Dio dalla vita pubblica, i pronostici di un futuro tecnologico e luminoso e poi basta che le viscere della terra brontolino appena ed eccoci qua, senza parole, a leccarci tremanti le ferite con l’augurio che stanotte vada meglio».
Parole a mio parere fuori luogo e inutili, che tendono a far intravvedere, in un modo pseudo subliminale, la relazione tra il comportamento “strafottente” degli uomini d’oggi e le catastrofi. Un richiamo inutile, poiché anche se non esaltassimo il progresso e non fossimo così strafottenti da allontanare Dio dalla vita pubblica e privata, rimarrebbero intatti la nostra fragilità e l’impotenza di fronte alla morte.
Buona domenica.
[…]
Abbia pazienza. Lei ha scritto:
“non giustifica il tentativo dell’amico Guzzo di voler suggerire tra le righe che la causa delle calamità naturali siano la diretta conseguenza dell’esaltazione del progresso e l’allontanamento strafottente di Dio dalla vita pubblica.”
In sostanza, Lei attribuisce a Guzzo la seguente affermazione: “l’esaltazione del Progresso e l’allontanamento strafottente di Dio dalla vita pubblica hanno come diretta conseguenza le calamita’ naturali”.
In altre parole, sembra che Guzzo creda ad una specie di divinità che s’arrabbia perché non crediamo piu’ in essa e quindi ci lancia contro catastrofi naturali.
Le parole di Guzzo mi sembra che dicano cose diverse, e continuo a non capire come Lei attribuisca loro una valenza che non c’e’ (e che se ci fosse, sarebbe veramente ridicola).
Concordo con Lei che, anche se non allontanassimo Dio dalla nostra vita pubblica e privata e non esaltassimo il progresso, la nostra fragilità comunque rimarrebbe. Ma forse sarebbe piu’ diffusa anche una certa realistica umiltà che, a mio modesto parere, ci aiuterebbe ad essere persone un poco migliori.
Buona giornata.