«La ferita dell’assenza di legami biologici resterà per sempre. È inutile negarlo o far finta di nulla»: toh, alla fine è arrivata. Tra le pieghe di un discorso articolato, sottovoce, ben mimetizzata tra le parole, però un’ammissione della filosofa e politica Michela Marzano sulla barbara realtà dell’utero in affitto o, come preferirebbe chiamarla lei, maternità surrogata è arrivata: «La ferita dell’assenza di legami biologici resterà per sempre». Ma questo vale anche per i bambini adottati, potrebbe ribattere qualcuno: e invece no. «La ferita dell’assenza di legami biologici», nel caso della cosiddetta maternità surrogata, è diversa e molto più grave sia perché originale – non tutti i bambini adottati non hanno conosciuto il seno materno, esperienza che a quasi tutti i figli dell’utero in affitto, invece, viene negata – sia perché programmata: il bambino adottato viene accolto in una famiglia perché quella originale non era in grado di provvedere a lui, quello comprato viene acquistato da una famiglia per la quale è stato “progettato”, concepito e messo al mondo.
Direi quindi che occorre parecchia immaginazione, volendo escludere la malafede, per porre sullo stesso piano adozione ed utero in affitto, due realtà totalmente distanti dal momento che una avviene nell’interesse del bambino e l’altra con l’acquisto del bambino. E’ però il caso, detto ciò, di tornare all’intervento di Michela Marzano pubblicato sul Corriere di ieri perché, se da un lato come si è visto contiene una ammissione di peso sull’utero in affitto – «La ferita dell’assenza di legami biologici resterà per sempre» -, dall’altro tenta di rendere presentabile questa pratica a-bo-mi-ne-vo-le (Copyright © Livia Turco): «Come accade in alcuni Stati che hanno legiferato sulla Gpa, una donna che si presta a questo tipo di pratiche dovrebbe sempre essere già madre e non dovrebbe mai trovarsi in una situazione economica tale da vedere nella Gpa l’unica opportunità per il sostentamento. Una forma di dono, quindi. Proprio come il dono di un rene o di un pezzo di fegato, sapendo che i rischi che si corrono sono importanti, ma che è grazie al proprio dono che si potrà salvare una vita» (Corriere della Sera, 17.3.2016, p. 28).
Ora, pur nel rispetto che dovuto a una studiosa di livello internazionale come Michela Marzano, l’accostamento fra la pratica della “maternità surrogata” e la dimensione del dono appare francamente insostenibile. Per tre ordini di motivi. Anzitutto per ragioni giuridiche: il citato «dono di un rene o di un pezzo di fegato» rientra nella casistica della donazione di organi e tessuti; ma la donazione degli organi e tessuti – si legge anche sul sito di A.I.D.O., acronimo che sta per Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – è un atto anonimo e gratuito di solidarietà per il quale non è consentita alcuna remunerazione economica e non è possibile conoscere l’identità del donatore e del ricevente. Ebbene, la cosiddetta maternità surrogata non solo non è anonima, non solo – anche laddove “altruistica” – non è mai gratuita, ma è essenzialmente un contratto; significa che, a gravidanza iniziata, la consegna del neonato per la madre “portatrice” è un “dono obbligato”, pena la risoluzione del contratto. Dunque l’accostamento fra la cosiddetta gestazione per altri e il dono, già giuridicamente, non regge.
E non regge neppure sul piano sociologico: se davvero la consegna del figlio da parte della madre “portatrice” nei confronti della parte committente fosse altruistica, per quale ragione questa versa sempre in condizioni economiche precarie? «Una donna che si presta a questo tipo di pratiche dovrebbe sempre essere già madre e non dovrebbe mai trovarsi in una situazione economica tale da vedere nella Gpa l’unica opportunità per il sostentamento», scrive Marzano. D’accordo, ma una europea o statunitense, magari già madre, che magari ha una casa di proprietà (magari con mutuo) e che sceglie diventa “portatrice” per pagare la retta universitaria ai figli è una donna davvero libera? Certo, non sarà poverissima come certe donne indiane, ma da qui a parlare di scelta libera e soprattutto di gesto altruistico nella vendita di un figlio, converrete, ne corre. E poi, scusate, che razza altruismo è mai quello che vede sempre e solo donne più povere dare figli a coppie più facoltose? Perché non si vedono mai donne benestanti “donare” figli a coppie povere? Perché “doni” sempre a senso unico?
Il parallelo “maternità surrogata” e dono, infine, non regge neppure sotto il profilo bioetico. Per una ragione molto semplice: il caso del «dono di un rene o di un pezzo di fegato» è un conto, ma con la cosiddetta gestazione per altri l’oggetto le dono è il figlio. Ma il figlio è una persona e le persone non si possono donare. Perché se così fosse, se le persone si potessero donare, è verosimile che, ben prima di quello dei figli, ad esplodere sarebbe anzitutto – come avrebbe ironizzato il bioeticista Mario Palmaro (1968–2014) – il dono delle suocere da parte dei mariti; purtroppo però per i mariti – e per fortuna delle suocere – gli esseri umani non si possono donare. Dunque la “maternità surrogata” – che non è accostabile né all’adozione, né al parto in anonimato né, meno ancora, alla donazione di organi – non solamente non costituisce una forma di dono, ma è totalmente inaccettabile. E stupisce che, pur di sostenere un’opinione diversa, fior di docenti universitari e studiosi si arrampichino sugli specchi confermando quanto scrive nel suo stupendo romanzo, L’ombra del vento, Carlos Ruiz Zafón: «Gli esseri umani sono disposti a credere a qualunque cosa tranne che alla verità».
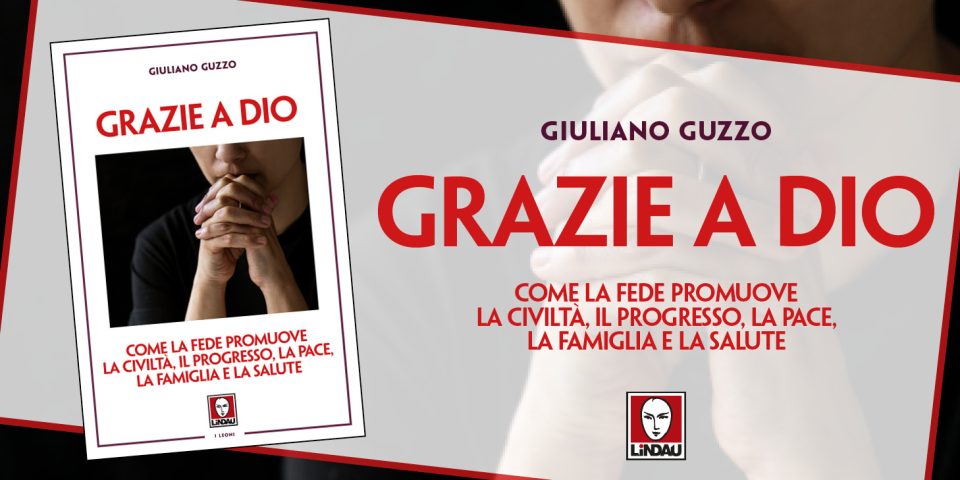

Da un’intervista a Fabrice Hadjadj
Intorno al dono effettivamente si è installata tutta una retorica moderna, dovuta soprattutto alla realtà dell’economia capitalista, per cui il dono appare come un argine alla logica del mercato. Ora, non è il dono in quanto tale ad essere una cosa cattiva, ovviamente, ma la logica del “dono di sé”, perché al centro mette il “sé”. Il punto non è dare se stessi all’altro, il punto è il bene dell’altro.
Non devo donare me stesso all’altro, devo ridonare l’altro a se stesso. E ciò implica il Bene. L’ha detto perfettamente Heidegger: «L’amore predispone uno spazio affinché l’altro possa donarsi all’altro, non solo a me che lo amo. E affinché possa essere se stesso, e non è se stesso se non nella sua relazione col bene»…Il peccato è di voler fare il bene con le sole proprie forze e secondo i propri piani….Pensiamo ai totalitarismi: hanno cercato di dare all’umanità una società perfetta, ma a partire dai propri piani, senza considerare il carattere irriducibile dell’altro, la singolarità di ogni essere umano. Il totalitarismo consiste nel voler dare all’uomo tutto, ma a partire da una teoria, da un’ideologia, e dunque in maniera totalmente riduttiva e soffocante, come si è visto nella storia.
A quando la prima piazzetta dedicata alle “donatrici di neonati”?